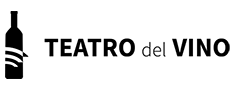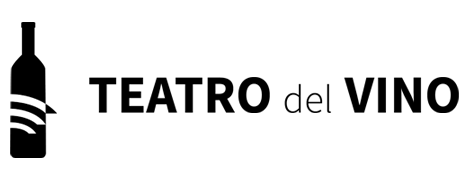Negli ultimi anni, la Valtellina si è distinta nel panorama enologico nazionale e internazionale, per aver restituito valore alla Chiavennasca o Nebbiolo delle Alpi. Un vitigno autoctono all’apparenza burbero e scontroso, ingentilito dalla mano dei viticoltori locali, che ne esaltano l’essenza.
È raro avvertire il silenzio in una regione frenetica come la Lombardia, adeguatasi alle richieste del “tempo industriale” che, spesso, nei ritmi naturali vede un limite alla profittabilità. Eppure, in tutto questo trambusto, c’è un luogo dove i minuti, le ore e i giorni scorrono ancora lentamente, in un quieto presente: la Valtellina.
La Chiavennasca in Valtellina: un elemento del paesaggio
Solcata dal Fiume Adda, che assieme al Lago di Como ne influenza il microclima, la Valtellina ha saputo distinguersi nel panorama enologico nazionale e internazionale per la valorizzazione della Chiavennasca.
Soprannominata anche “Nebbiolo delle Alpi”, per la sua somiglianza genetica e ampelografica con la celebre uva piemontese, probabilmente prende il nome dal termine diualettale “ciu-vensca” ossia “vitigno con più linfa e vigore”. E in effetti sono proprio la rusticità e capacità di adattamento a condizioni pedo-climatiche difficili, a aver favorito la diffusione ella Chiavennasca su larga scala, fino ad occupare quasi il 90% dell’intera superficie vitata valtellinese.
Le viti crescono su pendii scoscesi, scanditi da terrazzamenti e muretti a secco – la cui arte è già stata riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’UNESCO. Un susseguirsi di filari che, attorno ai rilievi su cui poggiano, “tessono” un abito dai colori cangianti, a seconda della stagione. Uno scenario tra i più suggestivi d’Italia, la cui integrità è preservata dalle quotidiane fatiche dei vignaioli locali.
La vendemmia – come pure gli altri lavori in vigna – è complessa: la pendenza dei vigneti, infatti, lascia spazio a sole operazioni manuali e richiede in media 1500 ore di lavoro per ettaro vitato, contro le circa 500 della collina – dato che si abbassa ulteriormente se ci spostiamo in pianura.
Cantina Arpepe: la storia del Nebbiolo delle Alpi
E se è vero che l’assaggio dei vini Nino Negri è imprescindibile per chi desideri approfondire la storia del Nebbiolo delle Alpi, quello dei vini Arpepe. non è da meno.
Un altro nome importante per la “Valtellina del Vino”, visibile già dalla strada che collega Sondrio a Bormio, ai piedi del Castello di Grumello, proprio dove si trova l’azienda vitivinicola fondata da Arturo Pelizzati Perego nel 1984. Quando si entra nella “viscere” della cantina, letteralmente scavata nella roccia, si ha la percezione del duro e costante lavoro che la Famiglia Pelizzati Perego affronta ogni giorno per promuovere la vera essenza del vitigno Chiavennasca. Un “cavallo di razza” vigoroso e imprevedibile che, per essere domato, richiede professionalità e gentilezza; la stessa che contraddistingue Isabella, impegnata assieme ai suoi due fratelli Guido ed Emanuele a perpetrare il sogno del padre, il cui ricordo si rinnova nel bicchiere ad ogni assaggio.
La vendemmia inizia tardi, a fine settembre, e avviene rigorosamente a mano. I grappoli, recisi e selezionati con attenzione, vengono sistemati in piccole cassette, issate sulle spalle dei “raccoglitori” e portati a valle per essere sottoposti prima al processo di pigia-diraspatura e poi a quello di fermentazione in capienti tini tronco-conici in legno. Un “sali e scendi” che si traduce in un importante sforzo fisico, che riassume perfettamente il concetto di viticoltura eroica.
«Non certo un mestiere adatto a chiunque ma l’unico che vorrei fare», afferma sorridendo Isabella.
Degustazione vini Arpepe
Un lavoro totalizzante e, al contempo, emozionante soprattutto quando si tratta di assaggiare le anteprime. La nostra degustazione, parte dal Rosso di Valtellina DOC, per arrivare al Valtellina Superiore DOCG e alle 6 Riserve – annata 2016, non ancora in commercio.
In particolare, tra le Riserve, segnaliamo il Valtellina Superiore Inferno Riserva “Sesto Canto” DOCG 2016: un vino che nasce da uve cresciute a 450 metri di quota, a ridosso del terzo tornante della strada denominata “Circuito dell’Inferno”. Macerato per 86 giorni in tini di legno da 50 ettolitri e affinato per altri 34 mesi in bottiglia, stupisce per gli intensi ed eleganti profumi di noce moscata, incenso ed eucalipto; profumi accompagnati da un sorso ampio, con tannini esuberanti, domati da una piacevole sapidità, che lega la bevuta in un finale lungo e minerale, quasi ferroso.

Non meno interessante è il Valtellina Superiore Sassella Riserva “Ultimi Raggi” DOCG 2016, la cui prima annata risale al 1999 – gli ultimi raggi del secolo, appunto. Un vino ottenuto a partire da uve surmature, raccolte nel mese di Novembre in zona Sassella a 600 metri d’altitudine. A questo punto dell’anno, le viti hanno già perso parte del proprio fogliame mentre gli acini presentano una buccia ispessita e una polpa particolarmente zuccherina, grazie alla lenta disidratazione. Una scelta, quella della vendemmia tardiva, che conduce ad un bouquet dai “toni caldi”, di frutta matura e spezie dolci: dalla ciliegia alla prugna, fino alla stecca di cannella. Aromi intriganti, che anticipano un sorso giocato sulle rotondità, con una trama tannica finissima – merito anche del lungo affinamento, che raggiunge quasi i 3 anni.
Una produzione, quella di Arpepe, che si aggira complessivamente sulle 100.000 unità annuali, sempre che non arrivi – puntuale e disgraziata – la grandine, già causa in passato di mancate vendemmie.
Fonte: Kevin Feragotto - Gazzettadelgusto.it