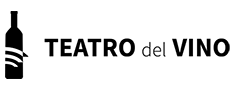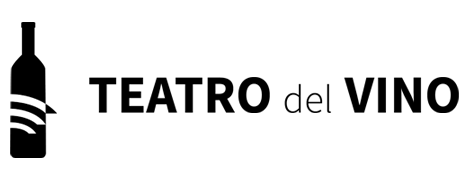Il 17 e il 18 febbraio si è tenuta la manifestazione Vini ad Arte, organizzata dal Consorzio Vini di Romagna. Era la prima volta che partecipavo a una rassegna dedicata principalmente al sangiovese dell’altra parte dell’Appennino, secondo un mio etnocentrico punto di vista che vuole la centralità del sangiovese in Toscana.
Il 17 e il 18 febbraio si è tenuta la manifestazione Vini ad Arte, organizzata dal Consorzio Vini di Romagna. Era la prima volta che partecipavo a una rassegna dedicata principalmente al sangiovese dell’altra parte dell’Appennino, secondo un mio etnocentrico punto di vista che vuole la centralità del sangiovese in Toscana.
Eppure il sangiovese romagnolo sta bene e gode di ottima salute con una denominazione dinamica che sta piano piano svincolandosi dall’immagine di vino industriale prodotto in quantità, nei grandi poli che è possibile vedere lungo l’autostrada Bologna-Ancona, per far approdare la conoscenza verso più rassicuranti luoghi di viticoltura artigianale.
A tale proposito è stata realizzata in modo opportuno una suddivisione territoriale del Sangiovese di Romagna al fine, appunto, di esaltare le peculiarità territoriali che questo vitigno riesce a declinare a seconda dell’origine geografica. Sono state quindi individuate 12 zone che, in generale, tagliano perpendicolarmente il territorio compreso tra l’Appennino e la pianura che collega Imola a Cattolica. Si è seguito saggiamente il corso dei numerosi fiumi e torrenti che hanno, nei secoli, plasmato i suoli che caratterizzano l’areale.
Nel corso del seminario introduttivo alla degustazione dal titolo “Romagna sangiovese, un carattere diverse peculiarità“ abbiamo assistito a nove video che descrivevano le caratteristiche delle sottozone che dal 2011 possono essere riportate in etichetta. Ecco nel seguente elenco le zone, da ovest a est, individuate con, tra parentesi, un’indicazione di massima dei suoli caratterizzanti:
Serra (argilla rossa, calcare nella parte appenninica)
Brisighella (argilla, calcare, gesso)
Marzeno (argilla, calcare e presenza di calanchi)
Oriolo (argille ferrose in basso e calcare in alto)
Modigliana (arenarie e argilla)
Castrocaro (argillosi e calanchi, sasso spungone)
Predappio (suoli pliocenici e sabbia in basso)
Bertinoro (argilla e suolo franco limoso)
Cesenate (suoli pluviali e ghiaia)
Longiano (argilla gialla e sabbia)
Non so perché siano state escluse le sottozone di Meldola e San Vicinio che credo risultino meno vitate rispetto al resto (almeno io così ho pensato).
Il lavoro di zonazione dell’areale si deve al grande lavoro di Alessandro Masnaghetti, il cui contributo è stato giustamente preso a esempio dal Consorzio e trasmesso al disciplinare di produzione enologica che oggi conta su una piramide qualitativa divisa in tre punti: alla base troviamo i Romagna Sangiovese, in mezzo i Romagna Sangiovese Superiore e in cima i Romagna Sangiovese Menzione Geografica. Tutte e queste categorie prevedono la dicitura Riserva se messi in commercio a due anni dalla vendemmia.
Insomma in generale si è lavorato molto bene, meglio che altrove sicuramente, per costruire un contesto geografico e legislativo tale da esaltare il carattere territoriale del Sangiovese romagnolo. E i vini?
Da quello che ho assaggiato – circa un centinaio di campioni che spaziavano dalle vendemmie 2018 alla 2015 – il comparto produttivo deve ancora registrare un cambio di passo nella direzione suggerita da un disciplinare così ben pensato. Se infatti vendemmie come la 2018 e la 2017 esibiscono vini di discreta fragranza con tannini vivi, esibiti e presenti sui quali il degustatore può innescare un ragionamento sull’origine e quindi riportare al palato ciò che è ben espresso sulla carta, nel caso della versione Riserva tale limpidezza di intenti si offusca in virtù di un rapporto vino-legno nella maggior parte dei casi mal gestito, ingenuo e caricaturale.
Niente di male per carità, siamo solo all’inizio di una presa di coscienza di valore per quel che concerne questa splendida zona, ma è bene suggerire di non ripetere oggi errori che in altre zone come la Toscana sono stati reiterati per anni.
Romagna Sangiovese Predappio Il Sangiovese 2018, Noelia Ricci
Succoso, definito nei profumi e dal tannino fine.
Fonte: Fabio Pracchia - SlowFood